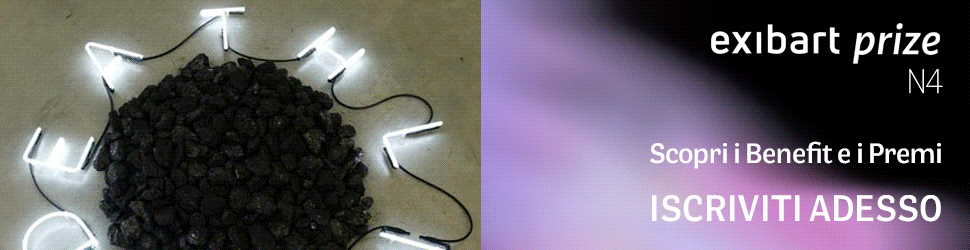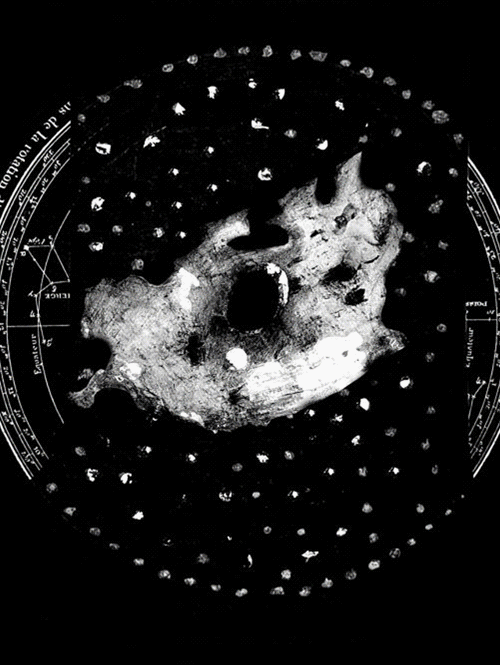opera
Ambienti interiori
| categoria | Scultura |
| soggetto | Figura umana, Architettura |
| tags | Gianni lucchesi+ |
| base | 20 cm |
| altezza | 196 cm |
| profondità | 20 cm |
| anno | 2019 |
In the box 2019
Capovolgere il distacco
di Nicolas Ballario
Tutto sta nel saper fare di un’assenza, una presenza.
Perché il desiderio è il peggiore compagno di viaggio per l’essere umano, è l’indicatore di una mancanza: c’è tutto il senso dell’infatuazione verso uno stato d’animo che c’era e non c’è più, o forse non c’è mai stato, in questi lavori in cui le forme diventano personaggi, i colori si fanno racconto, il materiale è paesaggio. Ed è incredibile vedere come nelle opere di Gianni Lucchesi l’apparato umano si faccia teatro, alzando il sipario su pulsioni che fanno sembrare l’artista sincero e bugiardo allo stesso tempo.
E siccome è nell’esaltazione delle differenze che si manifesta il lessico dell’artista, vediamo che tanto più una cosa a Lucchesi pare contradditoria, tanto più definita s’ingegna che venga riconosciuta, costringendoci a essere cavie di un suo esperimento: la reazione provocata dal guardare, dall’occhio, è più forte di quella generata dal sapere? Se sì, il cortocircuito estetico di vedere la radice di un albero chiusa in una stanza, o la frattura di un osso trattata come cimelio, non ci darà fastidio.
E come per molti artisti che fanno della relazione il punto focale del loro linguaggio, anche per Gianni Lucchesi l’aspetto tattile dell’arte è molto importante.
Però, attenzione, lui sa che le sue sono opere delicate e che non può farle toccare da chiunque, e riesce allora a creare una sorta di tattilità dello sguardo: le sue straordinarie creazioni ci parlano del legame e di una visione di un mondo di relazioni e a vederle sembra quasi di averle in mano.
E con quei piccoli omini a me non sembra solo di poter interagire, ma credo di averli sul mio corpo dentro e fuori, sulla testa, nel cuore, nel cervello, nei reni, nel fegato, sulle spalle e sulle ginocchia. Quel cubo sono io e le pose di quelle miniature sono il mio sentire, che si manifesta ipocritamente diverso dall’interno all’esterno.
Però, attenzione, l’inganno non riguarda solamente la relazione con l’altro, ma anche quella con noi stessi.
Si può mentire persino in sogno, che è il momento in cui perdiamo il controllo dei sensi, quindi figuriamoci quando abbiamo la lucidità del pensiero. E allora non cadiamo nel fraintendimento che quella di Lucchesi possa essere a tratti una pittura astratta e in altri un’arte figurativa, perché non può essere catalogata: non c’è differenza tra le forme che ricordano l’informale Franz Kline e i modellini che ci fanno pensare alle teche dei fratelli Chapman, perché è tutta un’urgenza espressiva che gli serve per rompere un silenzio del quale non farebbe a meno, se non fosse per l’imbarazzo che proverebbe a sceglierlo come strada.
Forse staremmo tutti meglio se insegnassimo ai bambini che non solo è possibile disegnare le persone, ma anche i sentimenti e le relazioni. Sarei felice di vedere Gianni Lucchesi in cattedra e credo che la sua materia potrebbe chiamarsi “punti di vista”, perché scardinare una conoscenza radicata è difficile e solo l’arte è in grado di farlo. E se spesso nel panorama contemporaneo si porta come punto di forza di un’artista la sua risolutezza, il suo essere pronto a qualunque cosa, a me piace che invece Lucchesi sia “indeciso a tutto”, perché ha capito che le nostre storie sono i nostri orti, ma anche i nostri ghetti. Il vissuto è il posto dove coltiviamo la nostra individualità, ma anche un muro che ci chiude in convenzioni, in obblighi, in censure e autocensure.
Mi ha raccontato che da ragazzino aveva una professoressa che dopo l’analisi del testo costringeva i suoi allievi a fare un grafico di ciò che avevano letto e mi viene da pensare che la parola trauma può essere vista in positivo. Bill Viola quando aveva solo sei anni, mentre giocava con i cuginetti è caduto in un lago. Non sapeva nuotare e mentre era immerso nell’acqua, o meglio mentre stava affogando, spalanca gli occhi e anziché andare nel panico ammira le forme della luce che si infrangono nel lago, i raggi di sole che scendono sott’acqua e illuminano quel paesaggio sotto la superficie. Per fortuna lo zio se ne accorge, appena in tempo, e lo salva. Ma quell’esperienza segnerà per sempre la vita di Viola, che da quel momento avrebbe cercato di riprodurre con le sue mani quel panorama poetico e intimo che aveva vissuto per una manciata di secondi.
Ecco Gianni Lucchesi ha avuto forse un trauma più soft (solo perché ha talento: se una professoressa avesse tentato di farlo con me, che non so tenere una matita in mano, probabilmente non sarebbe più tra noi) e questo lo ha segnato spingendolo a osare fino a suggerire l’inimmaginabile. E siccome è nella ricerca che si trova il senso dell’essere vivi, Lucchesi sta inseguendo probabilmente una via che lo porti alla pazzia, in modo da poter dire tutto, che è poi il non dover dire più nulla.
E quella sua ricerca continua di intrecci emotivi e viscerali, di insofferenza tra materiali e forme, di contatti tra sagome e contiguità di atteggiamenti, di relazione tra profili e legami tra impulsi, altro non è che il tentativo di colmare un vuoto, di riempire una casella della sua vita che ancora non riesce a definire. Insomma, di capovolgere un distacco. Perché tutto sta nel saper fare di un’assenza, una presenza.
Capovolgere il distacco
di Nicolas Ballario
Tutto sta nel saper fare di un’assenza, una presenza.
Perché il desiderio è il peggiore compagno di viaggio per l’essere umano, è l’indicatore di una mancanza: c’è tutto il senso dell’infatuazione verso uno stato d’animo che c’era e non c’è più, o forse non c’è mai stato, in questi lavori in cui le forme diventano personaggi, i colori si fanno racconto, il materiale è paesaggio. Ed è incredibile vedere come nelle opere di Gianni Lucchesi l’apparato umano si faccia teatro, alzando il sipario su pulsioni che fanno sembrare l’artista sincero e bugiardo allo stesso tempo.
E siccome è nell’esaltazione delle differenze che si manifesta il lessico dell’artista, vediamo che tanto più una cosa a Lucchesi pare contradditoria, tanto più definita s’ingegna che venga riconosciuta, costringendoci a essere cavie di un suo esperimento: la reazione provocata dal guardare, dall’occhio, è più forte di quella generata dal sapere? Se sì, il cortocircuito estetico di vedere la radice di un albero chiusa in una stanza, o la frattura di un osso trattata come cimelio, non ci darà fastidio.
E come per molti artisti che fanno della relazione il punto focale del loro linguaggio, anche per Gianni Lucchesi l’aspetto tattile dell’arte è molto importante.
Però, attenzione, lui sa che le sue sono opere delicate e che non può farle toccare da chiunque, e riesce allora a creare una sorta di tattilità dello sguardo: le sue straordinarie creazioni ci parlano del legame e di una visione di un mondo di relazioni e a vederle sembra quasi di averle in mano.
E con quei piccoli omini a me non sembra solo di poter interagire, ma credo di averli sul mio corpo dentro e fuori, sulla testa, nel cuore, nel cervello, nei reni, nel fegato, sulle spalle e sulle ginocchia. Quel cubo sono io e le pose di quelle miniature sono il mio sentire, che si manifesta ipocritamente diverso dall’interno all’esterno.
Però, attenzione, l’inganno non riguarda solamente la relazione con l’altro, ma anche quella con noi stessi.
Si può mentire persino in sogno, che è il momento in cui perdiamo il controllo dei sensi, quindi figuriamoci quando abbiamo la lucidità del pensiero. E allora non cadiamo nel fraintendimento che quella di Lucchesi possa essere a tratti una pittura astratta e in altri un’arte figurativa, perché non può essere catalogata: non c’è differenza tra le forme che ricordano l’informale Franz Kline e i modellini che ci fanno pensare alle teche dei fratelli Chapman, perché è tutta un’urgenza espressiva che gli serve per rompere un silenzio del quale non farebbe a meno, se non fosse per l’imbarazzo che proverebbe a sceglierlo come strada.
Forse staremmo tutti meglio se insegnassimo ai bambini che non solo è possibile disegnare le persone, ma anche i sentimenti e le relazioni. Sarei felice di vedere Gianni Lucchesi in cattedra e credo che la sua materia potrebbe chiamarsi “punti di vista”, perché scardinare una conoscenza radicata è difficile e solo l’arte è in grado di farlo. E se spesso nel panorama contemporaneo si porta come punto di forza di un’artista la sua risolutezza, il suo essere pronto a qualunque cosa, a me piace che invece Lucchesi sia “indeciso a tutto”, perché ha capito che le nostre storie sono i nostri orti, ma anche i nostri ghetti. Il vissuto è il posto dove coltiviamo la nostra individualità, ma anche un muro che ci chiude in convenzioni, in obblighi, in censure e autocensure.
Mi ha raccontato che da ragazzino aveva una professoressa che dopo l’analisi del testo costringeva i suoi allievi a fare un grafico di ciò che avevano letto e mi viene da pensare che la parola trauma può essere vista in positivo. Bill Viola quando aveva solo sei anni, mentre giocava con i cuginetti è caduto in un lago. Non sapeva nuotare e mentre era immerso nell’acqua, o meglio mentre stava affogando, spalanca gli occhi e anziché andare nel panico ammira le forme della luce che si infrangono nel lago, i raggi di sole che scendono sott’acqua e illuminano quel paesaggio sotto la superficie. Per fortuna lo zio se ne accorge, appena in tempo, e lo salva. Ma quell’esperienza segnerà per sempre la vita di Viola, che da quel momento avrebbe cercato di riprodurre con le sue mani quel panorama poetico e intimo che aveva vissuto per una manciata di secondi.
Ecco Gianni Lucchesi ha avuto forse un trauma più soft (solo perché ha talento: se una professoressa avesse tentato di farlo con me, che non so tenere una matita in mano, probabilmente non sarebbe più tra noi) e questo lo ha segnato spingendolo a osare fino a suggerire l’inimmaginabile. E siccome è nella ricerca che si trova il senso dell’essere vivi, Lucchesi sta inseguendo probabilmente una via che lo porti alla pazzia, in modo da poter dire tutto, che è poi il non dover dire più nulla.
E quella sua ricerca continua di intrecci emotivi e viscerali, di insofferenza tra materiali e forme, di contatti tra sagome e contiguità di atteggiamenti, di relazione tra profili e legami tra impulsi, altro non è che il tentativo di colmare un vuoto, di riempire una casella della sua vita che ancora non riesce a definire. Insomma, di capovolgere un distacco. Perché tutto sta nel saper fare di un’assenza, una presenza.